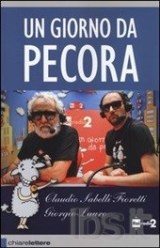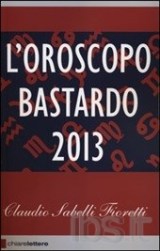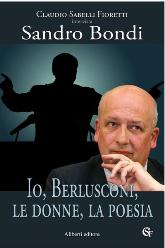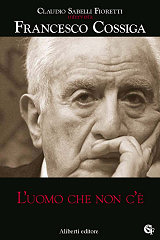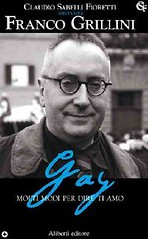- 14 Agosto 2013
Un po’ di autobriografia. Ho cominciato come giornalista sportivo perché mio padre era un giornalista sportivo. Famoso. E lui mi faceva vivere nell’ambiente dello sport, fra mondiali, giri, Olimpiadi. Ero piccolo quando vidi Vladimir Kuts battere il record dei 5 mila all’Olimpico. Ero a Reims quando Baldini vinse i mondiali di ciclismo (correva ancora Coppi). Avevo 8 anni quando la mia famiglia si trasferì a Cortina d’Ampezzo perché mio padre lavorava nell’organizzazione. Da allora un’Olimpiade dietro l’altra, Roma, Grenoble, Monaco, Innsbruck, Seul. Con un sempre maggior disamore per lo sport. Perché mio padre mi aveva insegnato che l’importante era partecipare, non vincere (a questo ci credevo poco perché avevo un notevole spirito agonistico, anche se avevo la deplorevole abitudine di arrivare sempre ultimo). Ma soprattutto mi aveva insegnato che esistevano i dilettanti e i professionisti. E che alle Olimpiadi partecipavano i dilettanti. E che il dilettante che mostrava una marca di scarponi veniva squalificato. D’accordo, il mondo va avanti e chissenefrega. Ma mi è venuto in mente mio padre quando ho letto che Federica Pellegrini aveva piantato una grana perché le sue medaglie d’oro non erano state “valutate” a sufficienza. E che la Filippi, che aveva vinto meno di lei, era stata “pagata” più di lei. Che cosa avrebbe pensato mio padre? Mah. Che cosa si può pensare di persone che guadagnano, grazie agli sponsor, un paio di milioni di euro e si lamentano per qualche spicciolo?